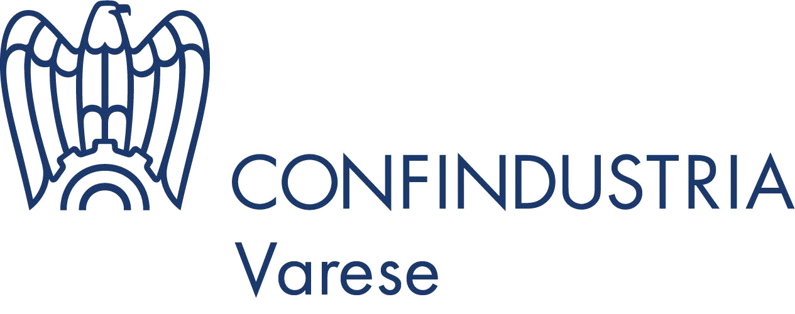Organizzato da Sperling e ASIPP (Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale), in collaborazione con MIPPE (Movimento Italiano Psicologia Perinatale) e SIPP (Società Italiana di Psicologia Perinatale), il Congresso Internazionale di Psicologia Perinatale, dal titolo "Nuovi Scenari della Paternità tra il Noto e l'Ignoto: Come Integrare Biologia e Necessità del Paterno Oggi", si è tenuto il 3 e 4 dicembre 2022 presso l'Ospedale Niguarda di Milano, riunendo professionisti appartenenti a diversi settori (tra cui Psicologia; Medicina e Chirurgia; Ostetricia; Infermieristica e Assistenza perinatale, solo per citarne alcuni), nonché tutti gli interessati al tema, con lo scopo di favorire un'integrazione multidisciplinare in grado di offrire un notevole valore aggiunto nell'efficace svolgimento di molteplici professioni.
Protagonista indiscussa del Congresso è stata la figura del padre e la sua centralità in termini di supporto perinatale, tematica da cui è scaturita una profonda riflessione sul ruolo svolto dai padri oggi, sia all'interno della diade genitoriale che in contesti relazionali sempre più complessi e difficili. Partendo dalla consapevolezza di una paternità in fase di transizione e in costante mutamento, il Congresso ha perseguito – e raggiunto, grazie alla presenza di svariate personalità di spicco, sia a livello nazionale che europeo, come il celebre promotore del parto senza violenza, il chirurgo francese Michel Odent – l'ambizioso obiettivo di rimettere in discussione modelli obsoleti e anacronistici, lasciando spazio ai nuovi scenari in cui si colloca la dimensione della paternità oggi, profondamente influenzata dai mutamenti culturali e antropologici che caratterizzano la società attuale.
Per l’occasione è stata scelta la modalità blended (il Congresso si è svolto in presenza, a Milano, restando comunque accessibile anche online, in diretta webinar), in modo da rendere più agevole la partecipazione all’evento, a prescindere dalla provenienza geografica degli iscritti.
Le due giornate del Congresso sono state contraddistinte da un susseguirsi di interventi dall'elevato valore formativo e potenziale ispirazionale, non soltanto in grado di favorire l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, ma anche di offrire numerose opportunità di riflessione a livello personale. In particolare, sono state discusse e analizzate tematiche di grande attualità: dal ruolo del padre nel periodo perinatale alla concezione di questa figura da un punto di vista antropologico e fenomenologico; dal vissuto paterno dinnanzi a un percorso di procrezione medicalmente assistita, a una nascita prematura o a un lutto; dalla paternità nell’immaginario collettivo agli aspetti antropologici e psicologici dei fattori di rischio nell’attaccamento padre-bambino; dai correlati neurobiologici legati alla paternità alla rivoluzione del maschile alla luce della teoria dell’attaccamento.
Dopo un primo spazio dedicato ai saluti da parte delle autorità presenti – tra cui il Dott. Federico Zanon, Vicepresidente di ENPAP e il Dott. Danilo Mazzacane, rappresentante dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano – il Congresso si è aperto con l'intervento del Prof. Franco Baldoni (Medico Specialista in Psicologia Medica, dottore di ricerca in Psicologia Clinica, Psicoanalista, Psicoterapeuta, Professore Associato in Psicologia Clinica), dal titolo "Il padre nel periodo perinatale. Aspetti antropologici, attaccamento familiare e psicopatologia". Partendo dal presupposto che, negli ultimi decenni, le ricerche sui disturbi affettivi perinatali, in particolare sulla depressione post-partum, si sono concentrate principalmente sulle madri, il Prof. Baldoni ha analizzato le ragioni principali all'origine di questa tendenza. In primo luogo, la funzione del padre è stata spesso sottovalutata dagli operatori sanitari. In secondo luogo, il Prof. Baldoni ha ricordato che i padri tendono generalmente a non richiedere supporto qualora soffrano di disturbi psicologici, mostrando riluttanza ad affrontare le difficoltà emotive e manifestando i sintomi in modo diverso rispetto alle madri, spesso minimizzandoli. Ne consegue che i disturbi affettivi maschili tendano a essere meno riconosciuti. Tuttavia, il Prof. Baldoni ha citato alcuni studi recenti i cui risultati dimostrano che la frequenza dei disturbi affettivi perinatali nei padri è simile a quella nelle madri. Tra questi, uno dei più significativi risulta essere la depressione perinatale paterna, condizione ancora non riconosciuta formalmente, tuttavia, dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V). Nei padri, la depressione è spesso accompagnata da ansia, somatizzazione, comportamenti aggressivi o dipendenze. Per una diagnosi più accurata, il Prof. Baldoni ha suggerito di ricorrere alla definizione "disturbo affettivo perinatale paterno", che include uno spettro più ampio di sintomi, nonché di utilizzare strumenti diagnostici specifici, sviluppati sulle caratteristiche della sintomatologia paterna, come il Perinatal Assessment of Paternal Affectivity (PAPA) (Baldoni et al., 2022).
Il secondo contributo della mattina è stato quello del Dott. Alessandro Volta (Pediatra Neonatologo e Direttore del Programma Materno Infantile dell’ASL di Reggio Emilia), che ha offerto "Uno sguardo antropologico e fenomenologico alla figura paterna". Il Dott. Volta ha ricordato innazitutto che, in passato, la nascita era vista come un processo esclusivamente femminile, con i padri generalmente esclusi. Negli ultimi decenni, invece, si è verificata una vera e propria "rivoluzione antropologica", che ha portato i padri a essere attivamente coinvolti durante il percorso nascita, mostrando un crescente interesse nei confronti della madre e del bambino. Nonostante ciò, persiste il pregiudizio che i padri non siano in grado di prendersi cura di un neonato, pregiudizio che continua a riflettersi nella tendenza, da parte di alcuni operatori, a sottovalutare l'importanza del loro ruolo. A fronte di queste premesse, il Dott. Volta ha sottolineato che, oggi, la partecipazione attiva del padre è considerata una risorsa preziosa, in grado di ridurre il rischio di depressione materna. Le ricerche evidenziano che i padri coinvolti nell'accudimento di un neonato sviluppano cambiamenti ormonali simili a quelli che interessano le madri, come l’aumento della produzione di ossitocina. Il Dott. Volta ha poi presentato una serie di studi sociologici i cui risultati dimostrano che l'assenza del padre ha conseguenze negative durevoli sullo sviluppo del bambino. È essenziale, inoltre, che il padre si relazioni con il bambino in modo autonomo, sviluppando il proprio stile di interazione. Il coinvolgimento della madre è cruciale, ma è necessario che il padre si senta libero di agire e di prendere iniziativa. Una relazione di coppia equilibrata è altresì fondamentale per il benessere del bambino, che apprende le basi delle dinamiche sociali osservando i genitori. Il Dott. Volta ha evidenziato, infine, la centralità degli operatori del percorso nascita nel supportare i padri verso una maturazione psicologica e sociale. La dimensione identitaria del padre è, infatti, più instabile rispetto a quella materna e necessita di un supporto continuo.
Il terzo Relatore a prendere la parola è stata una personalità di spicco a livello internazionale: il Prof. Michel Odent, celebre medico chirurgo francese, noto per il suo ruolo da pioniere – tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta – rispetto alla promozione di pratiche come l'allattamento subito dopo la nascita, l'utilizzo della vasca da parto e l'applicazione della Gate Control Theory of Pain in ostetricia. Nel suo intervento, intitolato "Le fasi ultimative della socializzazione del parto", il Prof. Odent ha esordito ricordando che, sebbene oggi sia considerata del tutto normale la presenza di figure di supporto accanto alla donna durante il parto, studi antropologici su popolazioni di epoca paleolitica hanno suggerito che, in passato, le donne tendevano a isolarsi al momento di partorire. Dal punto di vista del Dott. Odent, quindi, la socializzazione del parto potrebbe essere intesa come una forma di dominazione sulla natura, attuata attraverso una regolamentazione della vita riproduttiva. Questo processo ha visto inizialmente il coinvolgimento di una o più fiugure femminili di supporto; negli ultimi decenni, tuttavia, si è verificata una progressiva mascolinizzazione dell’ambiente del parto, con l’introduzione di professionisti sanitari di sesso maschile e la partecipazione attiva dei padri. Questo fenomeno è emerso rapidamente a partire dagli anni Settanta, in risposta all'ospedalizzazione del parto e ai cambiamenti sociali dell'epoca, ed è stato inizialmente reputato – a priori – positivo sia per l'esito del parto che per i legami familiari. Tuttavia, a distanza di cinquant'anni, il Prof. Odent ha concluso che, in realtà, la questione non è poi così semplice: sarebbe opportuno rivalutare tale fenomeno alla luce di considerazioni emerse da una scrupolosa osservazione empirica.
La sessione mattutina della prima giornata del Congresso si è conclusa con un'intensa sessione di domande e risposte, seguita dalla pausa pranzo. La sessione pomeridiana si è aperta, invece, con l'intervento della Dott.ssa Anna Rossetti (Ostetrica e Direttrice didattica della Scuola ElementaLe di Arte Ostetrica di Firenze SEAO e della casa editrice SEAO Edizioni), dal titolo “Il corpo del padre, il corpo della relazione. Prospettiva salutogenica nell’accompagnamento pre e post-natale". In primo luogo, la Dott.ssa Rosetti ha argomentato che l'accompagnamento clinico alla gravidanza, al parto e all’esogestazione dovrebbe includere anche il sostegno e la preparazione del padre, aspetto spesso trascurato nell'assistenza ostetrica, che tende a concentrarsi esclusivamente sulla madre. In secondo luogo, ha ricordato che il coinvolgimento del padre e l'esperienza della paternità passano anche attraverso il corpo, sia a livello biologico che psico-neuro-endocrino. Sfortunatamente, il mito di una paternità in cui la figura paterna è relegata al ruolo di mera "guida morale", distante dagli aspetti biologici della genitorialità, ha contribuito a separare i bisogni reali dei padri dall'assistenza a loro dedicata. Il modello della Midwifery Care, basato sulla Salutogenesi di Antonovsky, mira a riconoscere e rafforzare le risorse che promuovono la salute, comprese quelle dei padri, biologicamente programmati per imparare a diventare genitori tanto quanto le madri. Gli ormoni della paternità, infatti, come ossitocina e prolattina, influenzano positivamente il cervello del padre, favorendo competenze che non solo supportano la salute del bambino e l'allattamento, ma anche il benessere mentale del padre stesso. La Dott.ssa Rossetti ha concluso evidenziando che i padri in grado di vivere la relazione con i figli utilizzando attivamente corpo, mente e cuore contribuiscono positivamente, sul lungo periodo, alla salute psico-fisica del bambino.
Il secondo intervento pomeridiano della prima giornata del Congresso è stato quello del Dott. Pier Luigi Righetti (Psicologo, Psicoterapeuta e Responsabile del Servizio di Psicologia del Dipartimento Materno-Infantile dell'Az. ULSS 3 Serenissima in Veneto), intitolato "PMA e Genitorialità: Uno sguardo al padre". Il Dott. Righetti ha esordito ricordando che la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è un fenomeno in crescita che solleva riflessioni mediche, biologiche, psicologiche, etiche e sociali. Si tratta di un processo finalizzato ad aiutare le coppie intenzionate a diventare genitori quando il desiderio di un figlio non si realizza spontaneamente. Attingendo a ricerche empiriche e alla propria esperienza clinica, il Dott. Righetti ha approfondito, in particolare, il rapporto tra Genitorialità, PMA Eterologa ed Epigenetica. Quest'ultima studia, nello specifico, l'influenza delll’ambiente (compresi i fattori psicologici e relazionali) sull’espressione del DNA. A questo proposito, il Dott. Righetti ha evidenziato che l’attaccamento e la genitorialità sono processi mediati da meccanismi epigenetici e anche la relazione padre-figlio sembra essere in grado di riflettersi sullo sviluppo genetico del bambino.
La sessione pomeridiana è proseguita con l'intervento della Dott.ssa Claudia Ravaldi (Psichiatra e Psicoterapeuta), che ha approfonditp un tema particolarmente delicato: "I padri di fronte al lutto". Il lutto perinatale comprende le emozioni, i pensieri e i comportamenti che le persone vivono dopo la perdita di un bambino durante la gravidanza o subito dopo la nascita. È un evento traumatico che può avere gravi conseguenze psicologiche sia per la donna che per la coppia. Nonostante siano disponibili molti studi sugli effetti del lutto perinatale sulle donne, pochi riguardano l'impatto sugli uomini. Le evidenze cliniche riportate dalla Dott.ssa Ravaldi dimostrano che gli uomini colpiti da un lutto perinatale vivono livelli di stress meno intensi ma più duraturi, spesso accompagnati da comportamenti di evitamento che possono sconfinare nell'abuso di sostanze. A questo proposito, la Dott.ssa Ravaldi ha evidenziato la forte influenza esercitata da una certa idea di mascolinità, che educa gli uomini a non mostrare le proprie emozioni, sforzandosi al contrario di apparire forti, positivi e privi di necessità emotive, non solo nell'espressione del lutto ma anche nella mancata ricerca di un sostegno psicologico. La Dott.ssa Ravaldi ha ricordato che affrontare il lutto perinatale anche nei padri è cruciale per ridurre il rischio di complicazioni e supportare il benessere della coppia nelle future esperienze di genitorialità. Uno studio retrospettivo ha mostrato, infatti, che gli uomini ricevono raramente un sostegno mirato, finendo spesso per essere considerati unicamente una fonte di supporto per la donna. La Dott.ssa Ravaldi ha concluso sottolinenado che un maggiore riconoscimento del loro dolore da parte degli operatori sanitari potrebbe migliorare non solo il benessere paterno, ma anche quello della coppia.
Il penultimo intervento della prima giornata del Congresso è stato quello della Dott.ssa Lucia Aite (Psicologa e Psicoterapeuta, collabora con il Dipartimento di Neonatologia Medica e Chirurgica dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma), intitolato "Essere padre in Terapia intensiva neonatale". La Dott.ssa Aite ha esordito ricordando che padre e madre hanno pari responsabilità nel rapporto con il bambino e che le relazioni primarie influenzano direttamente lo sviluppo cognitivo ed emotivo di quest'ultimo, con effetti a lungo termine sulla sua salute psico-fisica. Negli ultimi 20 anni, i padri hanno assunto un ruolo sempre più attivo nell'accudimento dei figli, dando vita al concetto di co-genitorialità. Quando un bambino nasce malato e deve essere ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale (TIN), i genitori affrontano una grande vulnerabilità psichica, vedendo svanire i sogni e le attese legate alla sua nascita. In TIN, il padre è chiamato a esercitare immediatamente la propria responsabilità e allo stesso tempo a trovare un modo di reggere l’impotenza che sperimenta nei confronti del figlio e della propria compagna: il contatto con la possibile morte del figlio, con la sofferenza legata all’invasività delle cure a cui è sottoposto, la delega forzata dell’accudimento, l’impossibilità di sperimentare una prossimità libera e intima con il bambino, possono rendere particolarmente difficile il percorso del divenire padre. In questo contesto, la Dott.ssa Aite ha sottolineato che il ruolo dell’équipe curante è fondamentale per sostenere entrambi i genitori, aiutandoli a riappropriarsi delle proprie competenze. Il compito dei professionisti sanitari è infatti quello di promuovere una "cultura del legame", favorendo il contatto e il sostegno emotivo, anche in un ambiente segnato dal dolore e dalla vicinanza con la morte. La dimissione dall’ospedale può rappresentare per la famiglia una sorta di "seconda nascita" e coincidere con la piena assunzione delle responsabilità genitoriali.
La prima giornata del Congresso di Psicologia Perinatale si è conclusa con il contributo della Dott.ssa Gisella Congia (Psicologa specializzata nel supporto alla genitorialità/perinatalità) dal titolo “Riflessioni sulla paternità attraverso il linguaggio e l'immaginario collettivo”, al termine del quale ha avuto luogo un secondo momento dedicato alle domande e allo scambio diretto con i partecipanti. La Dott.ssa Congia ha realizzato un'analisi approfondita della figura paterna, riflettendo su come immagini culturali e narrazioni condivise abbiano plasmato la percezione di paternità nel corso deltempo. In particolare, la Dott.ssa Congia ha evidenziato quanto il processo di trasformazione della figura paterna – favorito da una de-tradizionalizzazione dei ruoli e da una crescente partecipazione dei padri all'accudimento dei figli – sollevi vari interrogativi culturali e sociali. Sebbene l'attuale concezione della genitorialità risulti sempre più indipendente dal determinismo biologico e dalla separazione tra maschile e femminile, il riconoscimento sociale delle qualità relative all'accudimento nei padri rimane limitato e spesso svalutato. La transizione verso una paternità post-patriarcale cerca di promuovere una visione più ampia e pluralistica del ruolo paterno, simile alla visione evolutiva della maternità. Secondo la Dott.ssa Congia, i cambiamenti nelle dinamiche familiari moderne offrono un terreno fertile per una nuova comprensione della paternità, capace di riconosce la molteplicità di modalità esistenti per assolvere a questo ruolo. Se, da un lato, ogni padre deve confrontarsi con la propria storia, le proprie aspettative e risorse per diventare il genitore che desidera essere, dall'altro, spetta agli operatori supportare e stimolare tale riflessione, rendendo possibile la costruzione di un’immagine di padre "sufficientemente buono".
Il primo Relatore a prendere la parola, dando ufficialmente il via alla seconda giornata del Congresso, è stato il Dott. Maurizio Quilici (Laureato in Giurisprudenza, specializzato in Diritto del Minore e in Mediazione Familiare), con un intervento intitolato "Il padre alla nascita: Un ruolo nuovo nella Storia". Il Dott. Quilici ha ricordato innanzitutto che, per secoli, gravidanza, parto e cura del neonato sono stati temi principalmente femminili, con il padre relegato a un ruolo marginale. Tuttavia, a partire dalla seconda metà del XX secolo, è iniziata una vera e propria "rivoluzione paterna" che ha profondamente trasformato il rapporto padre-figlio, generando un crescente interesse per la figura paterna all'interno di svariate discipline e incoraggiando la diffusione di studi e ricerche in tal senso. A partire dagli anni Settanta, molti studiosi hanno iniziato a rivalutatare l'importanza del padre nell'accudimento dei figli, riconoscendo la funzione paterna come "necessità costitutiva dell’essere umano". Oggi, sebbene persista lo stereotipo secondo cui un uomo non è adatto a occuparsi di un neonato, sono in atto importanti cambiamenti: molti padri partecipano, ad esempio, ai corsi pre-parto, assistono al parto, o ricercano gruppi di supporto a loro riservati. Inoltre, temi come la depressione perinatale paterna sono divenuti oggetto di studio. Secondo il Dott. Qulici, tutto questo riflette un profondo cambiamento culturale, che vede i padri diventare figure attive e coinvolte sin dall'inizio della vita del bambino. Le dinamiche familiari stanno evolvendo, e il concetto di triade madre-padre-figlio sta sostituendo quello di diade madre-figlio, confermando il ruolo centrale del padre nella crescita del bambino.
Il secondo intervento della mattinata è stato quello del Prof. Roberto Ravera (Primario della Struttura Complessa di Psicologia dal 2006, Docente di Etnopsicologia Clinica presso l’Università IUS di Torino e l’Università di Assam in India), intitolato “Analisi antropologica e psicologica dei fattori di rischio nell’attaccamento padre-bambino”. Attingendo alla sua pluriennale esperienza di lavoro clinico e antropologico nell’Africa Occidentale, il Prof. Ravera ha illustrato gli aspetti teorici e clinici alla base del costrutto progettuale nel lavoro con bambini vittime di trascuratezza e abusi presenti nei carceri minorili. In particolare, il Prof. Ravera ha messo in luce che, nei percorsi terapeutici e riabilitativi di questi minori, il riferimento alla figura paterna e al senso di appartenenza risultano fondamentali ai fini dell'elaborazione del trauma da separazione e della perdita.
Dopo una breve pausa, è stata la volta della Prof.ssa Cristina Trentini (Psicologa, Dottore di Ricerca in Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo; Professore associato presso l’Università “Sapienza” di Roma), che ha presentato una panoramica completa su "I correlati psicodinamici e neurobiologici della paternità". La Dott.ssa Trentini ha ricordato innanzitutto che, a partire dagli anni Settanta, la ricerca sui neonati ha indagato principalmente due aspetti chiave: la presenza di capacità percettive e comunicative innate nei neonati, che li predispongono allo scambio sociale, e l'influenza delle risposte genitoriali nell'evoluzione di queste competenze. I genitori, in particolare, sono motivati a rispondere ai segnali emotivi dei figli grazie a caratteristiche fisiche innate del neonato. Durante la gravidanza, sia le madri che i padri attraversano trasformazioni psichiche e neurobiologiche che facilitano la lettura dei segnali emotivi del bambino e il suo benessere psico-fisico. Le neuroscienze hanno dimostrato che, mentre nelle madri i cambiamenti ormonali (come la produzione di ossitocina e vasopressina) favoriscono il legame di attaccamento, anche i padri, sebbene in modo meno intenso, subiscono trasformazioni ormonali simili. La Dott.ssa Trentini ha sottolineato, inoltre, che gli studi di neuroimaging sulle madri hanno rivelato l'attivazione di specifiche aree cerebrali legate a motivazione, empatia e regolazione emotiva in risposta ai segnali del bambino. Anche negli studi sui padri è stata osservata un'attivazione cerebrale simile, ma con specificità che potrebbero distinguere – pur mantenendone la complementarità – i contributi dei genitori all’interno della relazione con il bambino.
La seconda giornata formativa è proseguita poi con l'intervento di Luca Trapanese, padre single di Alba, una bambina con la sindrome di Down, adottata nel 2018. Trapenese è stato il primo uomo single in Italia ad essere riuscito ad adottare un bambino. Nel 2007, ha fondato la Onlus “A Ruota Libera" con l'obiettivo di realizzare una lunga serie di progetti legati alla disabilità. Nel 2016, inoltre, ha fondato due case famiglia per bambini con gravi malformazioni, disabilità o forme tumorali che vengono abbandonati negli ospedali: “La Casa di Matteo”. Durante una presentazione lucida ma toccante, definita da molti dei partecipanti un'importante fonte di ispirazione, Trapenese ha attinto al proprio vissuto personale e all'esperienza genitoriale relativa all'accudimento di Alba, ricordando che "Nessuno è imperfetto".
Il Congresso si è concluso con il contributo finale della Dott.ssa Giuliana Mieli (Psicologa e Consulente, per oltre vent’anni, presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza e dell’ospedale San Giuseppe di Milano), dal titolo: “Autorità versus autorevolezza: La rivoluzione del maschile alla luce della teoria dell'attaccamento”. Partendo dal presupposto che la teoria dell'attaccamento ha rivoluzionato profondamente la Psicologia, la Dott.ssa Mieli ha citato il lavoro di John Bowlby, il quale sottolineava l'importanza delle relazioni affettive nei primi mille giorni di vita del bambino. Bowlby riteneva, infatti, che la qualità di tali legami fosse essenziale per la salute fisica e mentale del bambino, e che non sarebbe stato sensato lasciare questo tipo di accudimento al caso. La Dott.ssa Mieli ha messo in luce, inoltre, che l'attaccamento è biologicamente influenzato dagli ormoni e risponde ai bisogni di protezione ed esplorazione del bambino. I ruoli materni e paterni sono complementari, nonché necessari per garantire la sicurezza del bambino, contribuendo entrambi alla sua progressiva indipendenza. A questo proposito, la Dott.ssa Mieli ha ricordato che il coinvolgimento del padre nella cura del bambino sin dalla prima infanzia richiede una trasformazione del ruolo paterno, storicamente legato a durezza e autoritarismo, verso una figura educativa capace di accogliere e sostenere la fragilità del bambino con autorevolezza ed esperienza.
La seconda giornata formativa si è conclusa, infine, con un'ultima, interessante sessione di domande e risposte, nonché con i saluti e i ringraziamenti da parte degli organizzatori.
Riassumendo, il Congresso "Nuovi Scenari della Paternità tra il Noto e l'Ignoto: Come Integrare Biologia e Necessità del Paterno Ogg" non ha rappresentato soltanto una preziosa opportunità formativa per tutti gli operatori coinvolti nel supporto alla genitorialità e nell'assistenza perinatale, ma anche – e soprattutto – uno spazio sicuro dedicato a una riflessione autentica e senza pregiudizi, aperta a tutti gli interessati, sulle profonde trasformazioni che, negli ultimi decenni, hanno interessato in modo specifico la figura paterna e il suo ruolo nell'accudimento e nella crescita dei figli.
Per chi si fosse perso questo evento unico, è possibile accedere ai contributi più rilevanti del Congresso Internazionale di Psicologia Perinatale del 2022 attraverso il seguente corso e-learning, disponibile a un prezzo scontato sino al 1° dicembre 2025:
https://store.grupposperling.it/it-it/corso/paternita-biologia-e-ruolo-attuale-4942.La Segreteria Congressi

In Sperling troverai spirito d’innovazione e ricerca dell’eccellenza in ogni servizio proposto.

Associata: